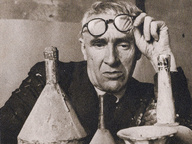Dal 15 maggio al 25 agosto a Palazzo Caffarelli
Filippo e Filippino Lippi, campioni di ingegno e bizzarrie, in mostra a Roma

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Samantha De Martin
14/05/2024
Roma - Vasari lo descrisse come “venereo”, follemente innamorato delle donne.
“Et era tanto perduto dietro a questo appetito, che all'opere prese da lui quando era di questo umore, poco o nulla attendeva". E probabilmente lo fu davvero Filippo Lippi, al punto da costringere Cosimo de’Medici a chiuderlo letteralmente nella sua residenza per indurlo a terminare una commissione scongiurando eventuali distrazioni che lo avrebbero distolto dalla sua attività di pittore dall’eccezionale talento. Ma Filippo Lippi sarebbe persino riuscito ad apparecchiare una rocambolesca fuga calandosi con un lenzuolo dalla finestra per correre dall’amata di turno.
Se è vera poi l’altra testimonianza dell'autore delle Vite, che vuole l’artista catturato dai Mori sul mare di Ancona mentre trascorreva una giornata in barca, per poi essere liberato dopo aver dipinto a carboncino l’immagine del loro signore, Lippi ci dà tutta l'impressione di aver davvero vissuto un'esistenza avventurosa.
Mentre si trovava a Prato a dipingere gli affreschi per il coro della Pieve, sedusse e rapì Lucrezia Buti, la bella diciassettenne del convento della città, dal cui amore nacque Filippino Lippi, il secondo gigante di questa storia avvincente.
La vita, e l’opera di Fra’ Filippo Lippi - maestro assoluto della stagione dorata del Rinascimento fiorentino, che amava la vita e nella cui pittura racchiuse l’idea monumentale della storia cristiana e di immagini votive che traevano la forza spirituale da una narrazione quanto più vicina possibile al vero, al quotidiano e alla mondanità del creato - si racconta in una bella mostra in programma dal 15 maggio al 25 agosto ai Musei Capitolini nelle sale di Palazzo Caffarelli.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Entrambi pittori e disegnatori di eccezionale talento, padre e figlio si ritrovano nel percorso Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, promosso da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
Anche la relazione tra Botticelli e i due Lippi è singolare. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi era stato discepolo presso Filippo Lippi. Da lui aveva appreso i rudimenti di una pittura di linea e colori e un’idea narrativa fatta di figure in pose piene di grazia. A sua volta Filippino si forma nella bottega di Botticelli, di lui poco più anziano, dove acquisisce anche parte degli elementi stilistici del padre. Questa triplice confluenza spiega l’uniformità di un linguaggio stilistico che si manifesta nella pittura fiorentina del Quattrocento, nonostante questi artisti dalla personalità unica e spiccata mantengano ciascuno la propria peculiarità espressiva.
L’uso del colore dà consistenza alle figure umane, la grazia scaturisce dai panneggi. Dopo Firenze, dove si trova dal 1481, arrivano gli incarichi importanti, come i tondi per il Palazzo Comunale di San Gimignano, ospiti d’eccezione in mostra, esempio lampante di uno stile maturo capace di creare una nuova intimità monumentale in spazi quotidiani dove il divino irrompe all'improvviso attraverso la perfezione della luce.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Ne l’Annunciazione dei Musei Civici di San Gimignano, realizzata in due separati tondi su tavola, Filippino Lippi conia le geometrie prospettiche e l’intima narrazione degli interni del padre guardando alle figure sinuose di Botticelli, aggiungendo una nuova profondità prospettico-paesaggistica a quei colorismi e alle trasparenze che determineranno la fortuna dell’artista nella grande produzione pittorica delle ultime decadi del Quattrocento, a Firenze come a Roma.
Nel percorso espositivo a cura di Claudia La Malfa, che intende illustrare, attraverso una selezione di dipinti, disegni e documenti d’archivio, il talento del pittore fiorentino Fra’ Filippo Lippi e quello di suo figlio Filippino, sfilano i capolavori di Filippo Lippi su tavola, come la Madonna Trivulzio del Castello Sforzesco di Milano, o la Madonna con angeli e committente della Collezione Cini di Venezia.
Il doppio registro, ufficiale e privato, che attraversa l’intera produzione pittorica di Lippi, si propone in mostra anche attraverso l’accostamento de l’Annunciazione della Vergine e i Santi Antonio Abate e Giovanni Battista, due piccole tavole della Galleria degli Uffizi, raramente esposte al pubblico, in dialogo con due tavole di grandi dimensioni raffiguranti i Santi Agostino e Ambrogio, Gregorio e Girolamo della Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Se il nucleo di documenti prestati dagli archivi di Firenze e di Spoleto evidenzia la rete di contatti del pittore con Cosimo de’ Medici e con il re di Napoli, raccontando la storia del rapimento da parte del pittore di Lucrezia Buti dal convento a Prato, la fuga d’amore dei due e la nascita del figlio Filippino, la selezione di disegni, arrivati dalla Galleria degli Uffizi e dall’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, prova il debito di Filippino Lippi, oltre che con il padre, anche con Sandro Botticelli.
Di particolare interesse in mostra è un disegno di Filippino proveniente dall’Accademia di Venezia che illustra l’ingegnosa invenzione realizzata nell’impresa ad affresco per la chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma nella cappella del cardinale napoletano Oliviero Carafa. Nel 1488 il cardinale aveva infatti chiamato l’artista per dipingere la sua monumentale cappella privata.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
L’esperienza romana avrebbe segnato un’ulteriore tappa nell’invenzione figurativa di Filippino nelle opere su tavola e negli affreschi della Cappella Strozzi cui lavora durante il suo ritorno a Firenze. La parete della cappella Carafa dove sono raffigurate l’Annunciazione alla Vergine e l’Assunzione della Vergine è una scatola cinese di immagini all’interno di altre immagini il cui ingegnoso meccanismo verrà svelato in mostra proprio attraverso l’esposizione del disegno in prestito dall’Accademia di Venezia. Acme della produzione pittorica di Filippino Lippi, la Cappella di Santa Maria sopra Minerva, non distante dai Musei Capitolini, è un crogiolo di citazioni dall’antico. Ci sono le grottesche e c’è la statua equestre del Marco Aurelio che all’epoca si trovava ancora a San Giovanni, la scultura di un re barbaro prigioniero, oggi nel cortile dei Capitolini, la piccola statua di un putto che gioca con un’oca. Presenze che rivelano il fascino magnetico esercitato da Roma sulla produzione artistica dei campioni del Rinascimento.
“Et era tanto perduto dietro a questo appetito, che all'opere prese da lui quando era di questo umore, poco o nulla attendeva". E probabilmente lo fu davvero Filippo Lippi, al punto da costringere Cosimo de’Medici a chiuderlo letteralmente nella sua residenza per indurlo a terminare una commissione scongiurando eventuali distrazioni che lo avrebbero distolto dalla sua attività di pittore dall’eccezionale talento. Ma Filippo Lippi sarebbe persino riuscito ad apparecchiare una rocambolesca fuga calandosi con un lenzuolo dalla finestra per correre dall’amata di turno.
Se è vera poi l’altra testimonianza dell'autore delle Vite, che vuole l’artista catturato dai Mori sul mare di Ancona mentre trascorreva una giornata in barca, per poi essere liberato dopo aver dipinto a carboncino l’immagine del loro signore, Lippi ci dà tutta l'impressione di aver davvero vissuto un'esistenza avventurosa.
Mentre si trovava a Prato a dipingere gli affreschi per il coro della Pieve, sedusse e rapì Lucrezia Buti, la bella diciassettenne del convento della città, dal cui amore nacque Filippino Lippi, il secondo gigante di questa storia avvincente.
La vita, e l’opera di Fra’ Filippo Lippi - maestro assoluto della stagione dorata del Rinascimento fiorentino, che amava la vita e nella cui pittura racchiuse l’idea monumentale della storia cristiana e di immagini votive che traevano la forza spirituale da una narrazione quanto più vicina possibile al vero, al quotidiano e alla mondanità del creato - si racconta in una bella mostra in programma dal 15 maggio al 25 agosto ai Musei Capitolini nelle sale di Palazzo Caffarelli.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Entrambi pittori e disegnatori di eccezionale talento, padre e figlio si ritrovano nel percorso Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, promosso da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
Anche la relazione tra Botticelli e i due Lippi è singolare. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi era stato discepolo presso Filippo Lippi. Da lui aveva appreso i rudimenti di una pittura di linea e colori e un’idea narrativa fatta di figure in pose piene di grazia. A sua volta Filippino si forma nella bottega di Botticelli, di lui poco più anziano, dove acquisisce anche parte degli elementi stilistici del padre. Questa triplice confluenza spiega l’uniformità di un linguaggio stilistico che si manifesta nella pittura fiorentina del Quattrocento, nonostante questi artisti dalla personalità unica e spiccata mantengano ciascuno la propria peculiarità espressiva.
L’uso del colore dà consistenza alle figure umane, la grazia scaturisce dai panneggi. Dopo Firenze, dove si trova dal 1481, arrivano gli incarichi importanti, come i tondi per il Palazzo Comunale di San Gimignano, ospiti d’eccezione in mostra, esempio lampante di uno stile maturo capace di creare una nuova intimità monumentale in spazi quotidiani dove il divino irrompe all'improvviso attraverso la perfezione della luce.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Ne l’Annunciazione dei Musei Civici di San Gimignano, realizzata in due separati tondi su tavola, Filippino Lippi conia le geometrie prospettiche e l’intima narrazione degli interni del padre guardando alle figure sinuose di Botticelli, aggiungendo una nuova profondità prospettico-paesaggistica a quei colorismi e alle trasparenze che determineranno la fortuna dell’artista nella grande produzione pittorica delle ultime decadi del Quattrocento, a Firenze come a Roma.
Nel percorso espositivo a cura di Claudia La Malfa, che intende illustrare, attraverso una selezione di dipinti, disegni e documenti d’archivio, il talento del pittore fiorentino Fra’ Filippo Lippi e quello di suo figlio Filippino, sfilano i capolavori di Filippo Lippi su tavola, come la Madonna Trivulzio del Castello Sforzesco di Milano, o la Madonna con angeli e committente della Collezione Cini di Venezia.
Il doppio registro, ufficiale e privato, che attraversa l’intera produzione pittorica di Lippi, si propone in mostra anche attraverso l’accostamento de l’Annunciazione della Vergine e i Santi Antonio Abate e Giovanni Battista, due piccole tavole della Galleria degli Uffizi, raramente esposte al pubblico, in dialogo con due tavole di grandi dimensioni raffiguranti i Santi Agostino e Ambrogio, Gregorio e Girolamo della Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
Se il nucleo di documenti prestati dagli archivi di Firenze e di Spoleto evidenzia la rete di contatti del pittore con Cosimo de’ Medici e con il re di Napoli, raccontando la storia del rapimento da parte del pittore di Lucrezia Buti dal convento a Prato, la fuga d’amore dei due e la nascita del figlio Filippino, la selezione di disegni, arrivati dalla Galleria degli Uffizi e dall’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, prova il debito di Filippino Lippi, oltre che con il padre, anche con Sandro Botticelli.
Di particolare interesse in mostra è un disegno di Filippino proveniente dall’Accademia di Venezia che illustra l’ingegnosa invenzione realizzata nell’impresa ad affresco per la chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma nella cappella del cardinale napoletano Oliviero Carafa. Nel 1488 il cardinale aveva infatti chiamato l’artista per dipingere la sua monumentale cappella privata.

Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab
L’esperienza romana avrebbe segnato un’ulteriore tappa nell’invenzione figurativa di Filippino nelle opere su tavola e negli affreschi della Cappella Strozzi cui lavora durante il suo ritorno a Firenze. La parete della cappella Carafa dove sono raffigurate l’Annunciazione alla Vergine e l’Assunzione della Vergine è una scatola cinese di immagini all’interno di altre immagini il cui ingegnoso meccanismo verrà svelato in mostra proprio attraverso l’esposizione del disegno in prestito dall’Accademia di Venezia. Acme della produzione pittorica di Filippino Lippi, la Cappella di Santa Maria sopra Minerva, non distante dai Musei Capitolini, è un crogiolo di citazioni dall’antico. Ci sono le grottesche e c’è la statua equestre del Marco Aurelio che all’epoca si trovava ancora a San Giovanni, la scultura di un re barbaro prigioniero, oggi nel cortile dei Capitolini, la piccola statua di un putto che gioca con un’oca. Presenze che rivelano il fascino magnetico esercitato da Roma sulla produzione artistica dei campioni del Rinascimento.
COMMENTI
LA MAPPA
NOTIZIE
VEDI ANCHE
-
 Mondo | Fino al 6 ottobre al MASI
Mondo | Fino al 6 ottobre al MASI
La scultura in movimento tra vuoto e leggerezza. Calder in mostra a Lugano
-
 Roma | A Palazzo delle Esposizioni dal 9 maggio al 9 giugno
Roma | A Palazzo delle Esposizioni dal 9 maggio al 9 giugno
In anteprima a Roma gli scatti del World Press Photo 2024
-
 Milano | Dal 14 maggio al 13 ottobre al Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Milano | Dal 14 maggio al 13 ottobre al Museo Diocesano Carlo Maria Martini
A Milano l'umanità di Robert Capa in 300 scatti
-
 Brescia | Dal 15 maggio il roadshow in giro per l’Italia
Brescia | Dal 15 maggio il roadshow in giro per l’Italia
Il Rinascimento inquieto di Brescia in una grande mostra
-
 Roma | A Roma dal 15 maggio al 3 ottobre
Roma | A Roma dal 15 maggio al 3 ottobre
Alle Terme di Caracalla la fotografia d'autore è nel segno di Narciso
-
 Bologna | A Bologna dal 3 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025
Bologna | A Bologna dal 3 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025
Ligabue protagonista dell'autunno di Palazzo Pallavicini