IL TEATRO FUTURISTA
30/07/2001
Un nuovo protagonista all’inizio del novecento si affacciò sui palcoscenici di tutti i teatri europei per stravolgerne i secolari meccanismi: il Futurismo!
Proprio il movimento italiano fu la prima avanguardia in Europa ad intuire l’importanza del teatro quale luogo socialmente privilegiato, capace infatti di trasmettere al grande pubblico nuove idee manifestando a pieno le moderne tecnologie che in quegli anni andavano rapidamente sviluppandosi.
Come già esposto in altre sedi, l’avanguardia italiana si fece paladina di un rinnovamento che doveva interessarsi ad ogni aspetto del vissuto, l’arte, la moda, l’arredo e via discorrendo; ma è proprio il teatro a rappresentare e mettere “in atto” la summa di tutti i principi estetici e concettuali che a partire dalla fine del primo decennio del novecento i protagonisti del movimento andavano sviluppando.
Il teatro infatti rappresentò quell’oasi felice dove poter esprimere direttamente alle vaste platee concetti nuovi, liberi da ogni contaminazione passatista, ma soprattutto luogo dove finalmente regnava incontrastata la dea dell’imprevedibilità che a contatto diretto con il pubblico creava qualcosa di mai visto prima.
Dimentichiamoci infatti che il palcoscenico futurista possa aver accolto testi drammatici o piéces di classica memoria: il loro non fu un teatro dominato dalla trama o dalle caratterizzazioni dei personaggi ma un teatro d’azione, azione che qui si connota come vera e propria gestualità. Scrisse Marinetti nel Manifesto dei drammaturghi futuristi (1911) che il loro era “ un teatro dello stupore, del record, della fisicofollia” e ancora “nato dalla fulminea intuizione, dalla attualità suggestionante e rivelatrice”.
Un altro aspetto di capitale importanza nel rinnovamento futurista fu la scenografia, ove, grazie anche agli apporti di artisti figurativi come Prampolini, Balla, Depero, si cercò di risolvere il problema-chiave dello spazio in rapporto con lo spettatore, che qui assurgeva a vero e proprio elemento dello spettacolo. La scena diveniva allora non spazio rappresentato ma attivo, dominato da elementi plastici e dinamici e da un acceso colorismo.
Tutto ciò possiamo trovarlo enunciato nel Manifesto della scenografia futurista pubblicato nel 1915, anche se andando a rileggere quelle pagine non proveremmo più lo stesso piacere e stupore che dovette aleggiare sulle platee fra Roma e Parigi, quando artisti del calibro di Balla, Depero, Prampolini, Russolo, realizzavano le scenografie per i “balletti russi” di Diaghilev oppure mettevano in scena la Pantomima futurista ad opera di Marinetti o di Prampolini. Qui per mezzo della suggestione coordinata della musica, della scenografia e del gesto gli oggetti si animavano ed erano protagonisti quanto gli attori.
Gran parte del mondo di allora applaudì questo nuovissimo modo di concepire la rappresentazione teatrale, finanche altre avanguardie artistiche quali Dada, dove uomini di primo piano come Tzara riuscirono ad intravedere nella frantumazione del linguaggio e nella caduta della barriera fra attore e spettatore, operata dai futuristi, l’entrata in scena di un fenomeno culturale che su di sè attirò le luci dei riflettori più importanti d’Europa.
LA MAPPA
NOTIZIE
VEDI ANCHE
-
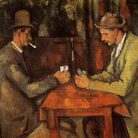 Da Dostoevskij a Yoko Ono: quando l'arte interpreta l'Homo Ludens
Da Dostoevskij a Yoko Ono: quando l'arte interpreta l'Homo Ludens
Il gioco nell’arte, tra destino e rappresentazione
-
 I programmi dal 23 al 29 febbraio
I programmi dal 23 al 29 febbraio
La settimana dell’arte in tv, da Brunelleschi a Matisse
-
 Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio
Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio
I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano
-
 Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio
Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio
La settimana in tv, dal Caravaggio perduto al mito di Tutankhamon
-
 Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli
Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli
Roma in noir con le atmosfere di Jack Vettriano
-
 Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Bernini e i Barberini. La nascita del Barocco si racconta a Roma


