NOTIZIE
-
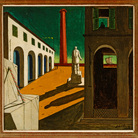 Milano | 2025-11-19 16:43:13
Un'Olimpiade Metafisica si apre a Milano
Milano | 2025-11-19 16:43:13
Un'Olimpiade Metafisica si apre a Milano
-
 Brescia | 2025-12-09 18:12:59
A Brescia Francesco Vezzoli dà nuova vita al mito, nel dialogo tra la Vittoria Alata e l'Idolino di Pesaro
Brescia | 2025-12-09 18:12:59
A Brescia Francesco Vezzoli dà nuova vita al mito, nel dialogo tra la Vittoria Alata e l'Idolino di Pesaro
-
 Milano | 2026-01-02 21:47:27
Le Alchimiste di Anselm Kiefer in arrivo a Milano
Milano | 2026-01-02 21:47:27
Le Alchimiste di Anselm Kiefer in arrivo a Milano
-
 Milano | 2026-01-27 19:53:25
Metafisica/Metafisiche: 100 anni di enigmi in mostra a Milano
Milano | 2026-01-27 19:53:25
Metafisica/Metafisiche: 100 anni di enigmi in mostra a Milano


